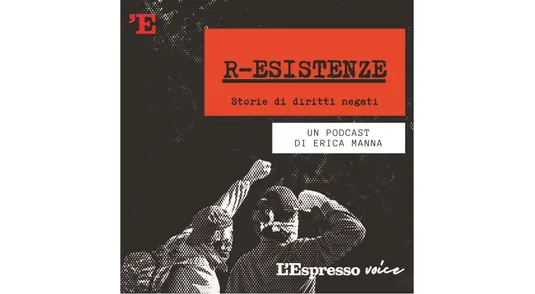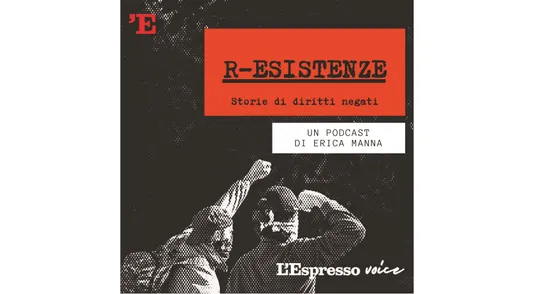La fuga dalla Somalia di un popolo stremato
La fuga dalla Somalia di un popolo stremato
Attentati, bombe, una guerra civile senza fine. Eppure il Paese è stato incluso nel “muslim ban” di Trump. Che colpisce un popolo stremato. Insieme ai profughi in arrivo a Mogadiscio dallo Yemen (Foto di Marco Gualazzini)
Anche lo Yemen, dove da due anni infuria una guerra atroce, è stato incluso nel “muslim ban” deciso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’America di oggi non vuole saperne di accogliere rifugiati che scappano dalle bombe sganciate dal miglior alleato di Washington nella regione, l’Arabia Saudita, i cui cittadini invece sono stati esclusi dall’ordine di Trump. E così J ami Abdul, profugo di quel conflitto, oggi si affida ad Allah: è scavato in volto, vestito di una camicia che lo avvolge come un sudario della dannazione terrena e, all’ora del tramonto, inginocchiato, solo, difronte all’Oceano Indiano, leva preghiere che corrono ad Oriente.
Jami è uno degli oltre 400 accampati al Lido di Mogadiscio, capitale della Somalia, anch’essa colpita dal rifiuto di Trump. Poco distante da lui, tra baracche e tende di stracci, una moltitudine eterogenea alza invocazioni di aiuto, che abbattono coordinate prestabilite e corrono in ogni direzione. Questuano cibo, medicine e pietà i rifugiati che vivono sul lungo mare della capitale somala, ai piedi dell’Arco di trionfo che gli italiani fecero erigere per la visita di Vittorio Emanuele III nel 1934. Ci sono ammalati e feriti, anziani e bambini, famiglie e orfani ma, ad accomunare tutti, l’esigenza del sopravvivere. Sono tutti yemeniti, in fuga dalla guerra civile esplosa nel loro Paese e approdati in una terra in balia di un altro ventennale conflitto. Hanno attraversato a bordo di barconi il golfo di Aden e sono sbarcati sulle coste somale, devastate da venticinque anni di scontri.
Le mosche sciamano nel campo rifugiati che accoglie le famiglie yemenite e il calore rende l’aria, già satura di incertezze e miseria, ancora più irrespirabile; gli uomini e le donne, privati del proprio presente, si trascinano come ombre sospese in un limbo del contingente, tra polvere e piccoli bracieri su cui vengono scaldate poche manciate di riso. «Io sono un rifugiato e non so quale sarà la mia vita», spiega Abdel Fatih Ahmed Mahmud, di venticinque anni. «Non ho più nulla, la mia casa è stata distrutta e i miei parenti uccisi; sono scappato, ma qua non c’è niente. Mancano cibo e assistenza medica. E poi c’è la guerra. Io voglio raggiungere l’Europa; non ho paura né del mare né del deserto: farò di tutto per arrivare in Germania». Il ragazzo mostra le ferite provocate dalle schegge durante un bombardamento e racconta anche di aver perso l’udito all’orecchio sinistro. La sua storia è gemella di quella di Ahmed Said, anche lui ventenne: «Ho attraversato il mare e adesso voglio partire per arrivare in Gran Bretagna, dove vive mio cugino. Sapevamo, quando siamo salpati, che in Somalia c’è la guerra, ma era la sola possibilità che avevamo per non morire subito».
[[ge:espresso:foto:1.294767:image:https://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.294767.1486121388!/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/articolo_480/image.JPG]]
Il miraggio dell’Occidente accomuna tutti i rifugiati, e il loro confidare ad alta voce il desiderio di raggiungerlo un messaggio d’aiuto racchiuso in bottiglia e lanciato in un mare di utopica fiducia nel mondo. Lo stesso mondo che oggi li rifiuta, ne ha paura e li etichetta come terroristi.
La Somalia oggi è allo stesso tempo terra di sbarchi e di fughe. Oltre ai civili in arrivo dallo Yemen, ci sono un milione di cittadini somali che hanno abbandonato il Paese e un altro milione sono i rifugiati interni. Lasciato alle spalle il campo che accoglie le famiglie yemenite, percorso il quartiere di Abdel Aziz, puntellato dalle case sventrate dai colpi di Rpg, superati i check point delle truppe governative e quelli delle milizie che imperversano nelle strade della capitale, compare la tendopoli Onat, dove vivono più di 700 famiglie somale. Hassan Omar Ahmet è un maestro coranico, che ha creato una madrassa tra le lamiere, dove insegna i precetti dell’Islam a decine di bambini perché, come spiega lui stesso, «in un Paese dove tutto è stato distrutto, anche la fede deve essere insegnata, partendo dalle fondamenta, alle nuove generazioni».
È scappato da un villaggio del nord, quando sono arrivati gli jihadisti di Al Shabaab e oggi non ha niente, se non una stuoia su cui dormire e un Corano con cui educare i bambini ai veri valori della religione. «Conosco alcuni ragazzi che sono scappati prima in Kenya e poi, da lì, fino alla Libia. C’è chi dice che servono più di 3.000 dollari per compiere tutto il viaggio. Non li ho e quindi non penso più ad andarmene, ma ad aiutare i giovani del campo». Testimone del ventennale conflitto somalo è anche Alima, che da venticinque anni vive ad Onat; è stata tra i primi ad arrivare quando la città venne travolta dallo scontro tra i signori della guerra. «Ho vissuto tutte le fasi del conflitto ma il periodo peggiore è subentrato con l’arrivo di Al Shabaab. Mi ricordo le incursioni nel campo, i bambini rapiti, le donne abusate e la violenza in ogni dove». Le parole dell’anziana donna, pronunciate da sotto un niqab arancione, anticipano l’eco di una raffica di kalashnikov. E poi, ancora, spari a rincorrersi poco distanti dal suo alloggio. I ragazzi e gli uomini scappano nei vicoli del campo cercando un rifugio, mentre la guerra con prepotenza conferma la sua presenza.
In Somalia oggi perdura lo scontro tra Al Shabaab e il contingente dell’Unione Africana, appoggiato dalle truppe dell’esercito somalo. Se è evidente che il conflitto rispetto al passato ha calato d’ intensità, allo stesso tempo però continua a incendiare la nazione e a destabilizzarla. I jihadisti infatti stanno affrontando una crisi interna e numerose sono le perdite subite negli ultimi anni, oltre alle continue ritirate nell’entroterra del Paese.
L’organizzazione terrorista sebbene appaia in procinto di essere sconfitta, non viene tuttavia mai decapitata e così, come una professionista della resurrezione, riesce continuamente a riorganizzarsi e a colpire. Oggi la tattica degli Shabaab è cambiata e i guerriglieri islamisti si sono specializzati in attacchi mirati contro obiettivi politici, militari e governativi: la loro strategia e il successo delle loro azioni è visibile nei loro continui agguati. Tra gli ultimi, quelli di venerdì 27 gennaio, quando un commando qaedista ha attaccato una base militare nel sud del Paese, dopo che solo due giorni prima un gruppo armato aveva ucciso 28 civili all’hotel Dayah di Mogadiscio, noto come punto di riferimento di molti imprenditori e politici. Gli attentati si sono fatti più frequnti con l’avvicinarsi alla data in cui dovrebbe essere eletto il nuovo presidente, l’8 febbraio, che potrebbe essere un passo verso la stabilizzazione del Paese.
[[ge:espresso:foto:1.294770:image:https://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.294770.1486121391!/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/articolo_480/image.JPG]]
Una speranza, insomma. Anche perché, nonostante la prosecuzione del conflitto e gli esodi umani, nella società somala ha incominciato ad affermarsi anche una voglia di cambiamento, un desiderio di spezzare l’assedio della paura e di mettere in scena, seppur in punta di piedi, il ritorno alla vita. È così che sul lungo mare di Mogadiscio alcune famiglie passeggiano e donne tingono l’acqua del mare con i loro i niqab colorati; nello stadio riprendono le partite di pallamano femminile e gli spalti, con ancora impressi i segni dei colpi di Ak47, vedono sedersi, gli uni accanto agli altri, giovani con magliette di calcio e ragazze velate che lasciano però intravvedere gli occhi truccati col kohl. E pure la notte ci sono quartieri dove i cittadini della capitale si ritrovano per fumare i narghilé, ascoltare musica locale e giocare a biliardo: come al Posh Treats, il centro benessere che Manara Moalin, una donna di 33 anni, cresciuta tra Napoli, Londra e Dubai, ha inaugurato sfidando le minacce di morte «La gioventù somala deve vivere, godere dei piaceri della vita che una guerra infinita le ha proibito. Io sono cresciuta lontano dalla mia terra, ma ora sono voluta tornare per dare il mio contributo al futuro del mio popolo», dice.
Da un lato zone rosse e spari, dall’altro risate e concerti. Un futuro di rinascita e un passato di dannazione si contendono il presente somalo, in bilico tra la speranza negata, che oggi diviene tangibile e l’eterna guerra che, come un morbo, ha intaccato l’identità del Paese.
Jami è uno degli oltre 400 accampati al Lido di Mogadiscio, capitale della Somalia, anch’essa colpita dal rifiuto di Trump. Poco distante da lui, tra baracche e tende di stracci, una moltitudine eterogenea alza invocazioni di aiuto, che abbattono coordinate prestabilite e corrono in ogni direzione. Questuano cibo, medicine e pietà i rifugiati che vivono sul lungo mare della capitale somala, ai piedi dell’Arco di trionfo che gli italiani fecero erigere per la visita di Vittorio Emanuele III nel 1934. Ci sono ammalati e feriti, anziani e bambini, famiglie e orfani ma, ad accomunare tutti, l’esigenza del sopravvivere. Sono tutti yemeniti, in fuga dalla guerra civile esplosa nel loro Paese e approdati in una terra in balia di un altro ventennale conflitto. Hanno attraversato a bordo di barconi il golfo di Aden e sono sbarcati sulle coste somale, devastate da venticinque anni di scontri.
Le mosche sciamano nel campo rifugiati che accoglie le famiglie yemenite e il calore rende l’aria, già satura di incertezze e miseria, ancora più irrespirabile; gli uomini e le donne, privati del proprio presente, si trascinano come ombre sospese in un limbo del contingente, tra polvere e piccoli bracieri su cui vengono scaldate poche manciate di riso. «Io sono un rifugiato e non so quale sarà la mia vita», spiega Abdel Fatih Ahmed Mahmud, di venticinque anni. «Non ho più nulla, la mia casa è stata distrutta e i miei parenti uccisi; sono scappato, ma qua non c’è niente. Mancano cibo e assistenza medica. E poi c’è la guerra. Io voglio raggiungere l’Europa; non ho paura né del mare né del deserto: farò di tutto per arrivare in Germania». Il ragazzo mostra le ferite provocate dalle schegge durante un bombardamento e racconta anche di aver perso l’udito all’orecchio sinistro. La sua storia è gemella di quella di Ahmed Said, anche lui ventenne: «Ho attraversato il mare e adesso voglio partire per arrivare in Gran Bretagna, dove vive mio cugino. Sapevamo, quando siamo salpati, che in Somalia c’è la guerra, ma era la sola possibilità che avevamo per non morire subito».
[[ge:espresso:foto:1.294767:image:https://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.294767.1486121388!/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/articolo_480/image.JPG]]
Il miraggio dell’Occidente accomuna tutti i rifugiati, e il loro confidare ad alta voce il desiderio di raggiungerlo un messaggio d’aiuto racchiuso in bottiglia e lanciato in un mare di utopica fiducia nel mondo. Lo stesso mondo che oggi li rifiuta, ne ha paura e li etichetta come terroristi.
La Somalia oggi è allo stesso tempo terra di sbarchi e di fughe. Oltre ai civili in arrivo dallo Yemen, ci sono un milione di cittadini somali che hanno abbandonato il Paese e un altro milione sono i rifugiati interni. Lasciato alle spalle il campo che accoglie le famiglie yemenite, percorso il quartiere di Abdel Aziz, puntellato dalle case sventrate dai colpi di Rpg, superati i check point delle truppe governative e quelli delle milizie che imperversano nelle strade della capitale, compare la tendopoli Onat, dove vivono più di 700 famiglie somale. Hassan Omar Ahmet è un maestro coranico, che ha creato una madrassa tra le lamiere, dove insegna i precetti dell’Islam a decine di bambini perché, come spiega lui stesso, «in un Paese dove tutto è stato distrutto, anche la fede deve essere insegnata, partendo dalle fondamenta, alle nuove generazioni».
È scappato da un villaggio del nord, quando sono arrivati gli jihadisti di Al Shabaab e oggi non ha niente, se non una stuoia su cui dormire e un Corano con cui educare i bambini ai veri valori della religione. «Conosco alcuni ragazzi che sono scappati prima in Kenya e poi, da lì, fino alla Libia. C’è chi dice che servono più di 3.000 dollari per compiere tutto il viaggio. Non li ho e quindi non penso più ad andarmene, ma ad aiutare i giovani del campo». Testimone del ventennale conflitto somalo è anche Alima, che da venticinque anni vive ad Onat; è stata tra i primi ad arrivare quando la città venne travolta dallo scontro tra i signori della guerra. «Ho vissuto tutte le fasi del conflitto ma il periodo peggiore è subentrato con l’arrivo di Al Shabaab. Mi ricordo le incursioni nel campo, i bambini rapiti, le donne abusate e la violenza in ogni dove». Le parole dell’anziana donna, pronunciate da sotto un niqab arancione, anticipano l’eco di una raffica di kalashnikov. E poi, ancora, spari a rincorrersi poco distanti dal suo alloggio. I ragazzi e gli uomini scappano nei vicoli del campo cercando un rifugio, mentre la guerra con prepotenza conferma la sua presenza.
In Somalia oggi perdura lo scontro tra Al Shabaab e il contingente dell’Unione Africana, appoggiato dalle truppe dell’esercito somalo. Se è evidente che il conflitto rispetto al passato ha calato d’ intensità, allo stesso tempo però continua a incendiare la nazione e a destabilizzarla. I jihadisti infatti stanno affrontando una crisi interna e numerose sono le perdite subite negli ultimi anni, oltre alle continue ritirate nell’entroterra del Paese.
L’organizzazione terrorista sebbene appaia in procinto di essere sconfitta, non viene tuttavia mai decapitata e così, come una professionista della resurrezione, riesce continuamente a riorganizzarsi e a colpire. Oggi la tattica degli Shabaab è cambiata e i guerriglieri islamisti si sono specializzati in attacchi mirati contro obiettivi politici, militari e governativi: la loro strategia e il successo delle loro azioni è visibile nei loro continui agguati. Tra gli ultimi, quelli di venerdì 27 gennaio, quando un commando qaedista ha attaccato una base militare nel sud del Paese, dopo che solo due giorni prima un gruppo armato aveva ucciso 28 civili all’hotel Dayah di Mogadiscio, noto come punto di riferimento di molti imprenditori e politici. Gli attentati si sono fatti più frequnti con l’avvicinarsi alla data in cui dovrebbe essere eletto il nuovo presidente, l’8 febbraio, che potrebbe essere un passo verso la stabilizzazione del Paese.
[[ge:espresso:foto:1.294770:image:https://espresso.repubblica.it/polopoly_fs/1.294770.1486121391!/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/articolo_480/image.JPG]]
Una speranza, insomma. Anche perché, nonostante la prosecuzione del conflitto e gli esodi umani, nella società somala ha incominciato ad affermarsi anche una voglia di cambiamento, un desiderio di spezzare l’assedio della paura e di mettere in scena, seppur in punta di piedi, il ritorno alla vita. È così che sul lungo mare di Mogadiscio alcune famiglie passeggiano e donne tingono l’acqua del mare con i loro i niqab colorati; nello stadio riprendono le partite di pallamano femminile e gli spalti, con ancora impressi i segni dei colpi di Ak47, vedono sedersi, gli uni accanto agli altri, giovani con magliette di calcio e ragazze velate che lasciano però intravvedere gli occhi truccati col kohl. E pure la notte ci sono quartieri dove i cittadini della capitale si ritrovano per fumare i narghilé, ascoltare musica locale e giocare a biliardo: come al Posh Treats, il centro benessere che Manara Moalin, una donna di 33 anni, cresciuta tra Napoli, Londra e Dubai, ha inaugurato sfidando le minacce di morte «La gioventù somala deve vivere, godere dei piaceri della vita che una guerra infinita le ha proibito. Io sono cresciuta lontano dalla mia terra, ma ora sono voluta tornare per dare il mio contributo al futuro del mio popolo», dice.
Da un lato zone rosse e spari, dall’altro risate e concerti. Un futuro di rinascita e un passato di dannazione si contendono il presente somalo, in bilico tra la speranza negata, che oggi diviene tangibile e l’eterna guerra che, come un morbo, ha intaccato l’identità del Paese.