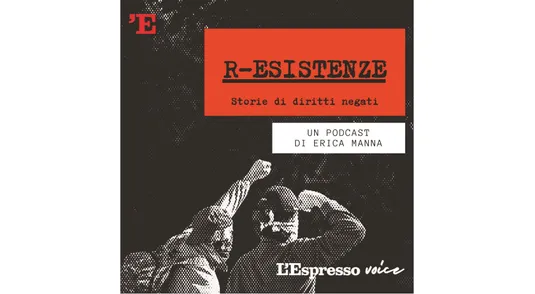Gaza, il divieto di importazione del cemento blocca la ricostruzione di un asilo per bimbi
Gaza, il divieto di importazione del cemento blocca la ricostruzione di un asilo per bimbi
In un villaggio della Striscia, la struttura costruita dalla cooperazione italiana era stata distrutta dall'esercito israeliano nell'estate del 2014, la stessa in cui moriva il videoreporter romano Simone Camilli. E a lui sarà dedicato il nuovo asilo in fase di ricostruzione. Tra mille difficoltà
Due storie dolorose, ciascuna a suo modo. Due storie, accadute a Gaza nell’estate del 2014, che si sono incrociate. A luglio i bulldozer dell’esercito israeliano radevano al suolo un asilo realizzato dalla cooperazione italiana in uno dei villaggi più disastrati della Striscia. Ad agosto, in un giorno di tregua tra Hamas e le forze israeliane, a causa dell’esplosione di un ordigno moriva a 35 anni il videoreporter romano Simone Camilli.
A distanza di mesi, quell’asilo sta rinascendo pezzo dopo pezzo grazie all’iniziativa di quanti l’avevano voluto in origine e anche grazie al contributo della famiglia del giovane giornalista. E proprio a lui verrà dedicata quella struttura che, nonostante gli ostacoli posti dalle autorità israeliane, cerca ancora di accogliere decine di bambini palestinesi.
Era il marzo del 2012 quando a Um al Nasser, villaggio beduino della Striscia di Gaza, si faceva festa per l’inaugurazione di un nuovo asilo. Aule per attività educative e ricreative, una mensa, un ambulatorio pediatrico e uno sportello di assistenza per le famiglie, c’era tutto quello che poteva servire all’interno della “Terra dei bambini”. Questo il nome della struttura realizzata con il contributo, tra gli altri, del nostro ministero degli Affari esteri, della Cooperazione italiana, della Conferenza episcopale e dell’organizzazione non governativa “Vento di Terra”, e progettata dallo studio di architettura Arcò insieme a quello di Mario Cucinella. Quel centro era diventato un laboratorio di buone prassi, un simbolo di speranza e un punto di riferimento per la popolazione di Um al Nasser.
Situato vicino al valico di Eretz, sul confine della cosiddetta “No go zone”, e circondato dai bacini di raccolta delle acque nere provenienti da tutto il nord della Striscia, il villaggio ha il 95 per cento di abitanti registrati come rifugiati, di cui il 60 per cento bambini, e un tasso di disoccupazione all’80 per cento, quasi il doppio della media regionale della Striscia. Um al Nasser, in piena area di conflitto tra Palestina e Israele, deve fare i conti con gli attacchi da parte dell’esercito israeliano. E la guerra lascia dietro di sé macerie e una serie di problematiche sanitarie e sociali. Per questo, alla “Terra dei bambini” erano previste pure attività di assistenza medica e psicologica per le sindromi da stress post-traumatico, oltre a servizi di sostegno per le mamme in difficoltà.
Un polo d’eccellenza, insomma: costruito in base a un progetto di architettura bioclimatica, dotato di pannelli fotovoltaici e di un impianto di fitodepurazione, l’asilo era stato realizzato con materiali poco costosi, facilmente reperibili sul territorio e particolarmente adatti a garantire l’isolamento e la funzionalità energetica della struttura.
Anche dal punto di vista dell’offerta formativa, la “Terra dei bambini” era un centro innovativo: gli insegnanti seguivano metodi pedagogici basati sul coinvolgimento diretto e sulla cosiddetta “educazione alla pace”. Un percorso per recuperare generazioni traumatizzate dalle violenze, per allontanarle dal rischio della radicalizzazione, per impedire che rabbia e dolore sfociassero nel desiderio di vendetta e nell’adesione al fondamentalismo.
Un percorso che è stato interrotto nella notte del 17 luglio 2014, quando la fanteria e i blindati israeliani impegnati nell’operazione “Protective Edge” hanno occupato il villaggio, obbligando l’intera comunità ad abbandonare le proprie case. I civili si sono diretti a piedi, sotto un intenso bombardamento, verso il campo profughi di Jabalia, dove sono stati costretti a vivere nella scarsità di medicinali, cibo e acqua potabile.
Al villaggio, intanto, le ruspe abbattevano un centinaio di abitazioni e la “Terra dei bambini”. Secondo le autorità israeliane, infatti, l’asilo serviva da copertura alle attività militari delle truppe islamiste e nascondeva l’accesso a tunnel che consentivano di uscire clandestinamente da Gaza. Accuse respinte dai gestori dell’asilo e mai verificate in concreto.
In quello stesso periodo Simone Camilli era rientrato a Gaza per documentare, per conto dell’agenzia “Associated Press”, la ripresa del conflitto e, in particolare, il problema delle bombe israeliane rimaste inesplose sul terreno. Il 13 agosto, insieme al cronista Ali Shehda Abu Afash che gli faceva da interprete e al fotografo Hatem Moussa, accompagnò una squadra di artificieri della polizia di Gaza per riprenderli con la sua telecamera.
Nel corso delle operazioni di disinnesco di un missile vicino a un campo di calcio a Beit Lahiya, la deflagrazione improvvisa dell’ordigno ha ucciso lui, l’interprete e tre poliziotti, mentre il fotografo è rimasto ferito.
Simone aveva già lavorato in aree di conflitto e, in particolare, nella Striscia: era stato lì nel 2012 per seguire l’operazione israeliana “Pilastro di Difesa”, nel 2011 per il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi in cambio della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit, tra il 2008 e il 2009 per l’operazione “Piombo Fuso” ed era stato lì anche negli anni precedenti per seguire altri eventi cruciali. Perché era così che intendeva la sua professione: voleva stare dove le cose succedono per vederle e raccontarle, voleva stare in prima linea, consapevole dei rischi e, insieme, della responsabilità che un giornalista ha nel descrivere la realtà. E anche in quell’estate di due anni fa, tra altri eventi che avrebbe potuto seguire per conto dell’agenzia, aveva scelto di tornare proprio a Gaza, nella terra che conosceva meglio e a cui aveva dedicato il documentario “About Gaza”, per continuare a testimoniare i risvolti umani e quelli meno noti della guerra. Per questo, grazie alla sensibilità e alla discrezione con cui raccontava la vita, le storie e le persone, era diventato un amico e un fratello per tutti coloro che aveva conosciuto sul posto.
Così, per rendere giustizia al coraggio e alla passione di Simone, ma anche per proseguirne l’impegno in quei territori a cui era profondamente legato, la sua famiglia ha deciso di sostenere progetti a favore della popolazione di Gaza. E l’idea di raccogliere fondi per ricostruire l’asilo di Um al Nasser è nata con la collaborazione di un amico di Simone, responsabile dei progetti a Gaza per conto di “Vento di Terra”.
Così, l’anno scorso i lavori sono partiti. È stato ricostruito e inaugurato il centro dedicato alle attività per le donne, dotato di un laboratorio di falegnameria e uno di sartoria, mentre la “Terra dei bambini” è stata temporaneamente riaperta in un edificio messo a disposizione dal Comune. Circa 130 bambini sono tornati a respirare un po’ di serenità tra le mura del loro asilo. Anche l’ambulatorio ha riaperto e sono ricominciate le attività di assistenza familiare e professionale.
Ma le difficoltà non mancano. I locali che ospitano il centro non sono abbastanza grandi e non sono sempre adeguati per il tipo di attività che vi si svolge. E il problema vero è che il progetto originario di ricostruzione è bloccato a causa del divieto d’importazione del cemento, imposto lo scorso aprile dal governo israeliano a tempo indeterminato. Il blocco è stato applicato in seguito alla scoperta di un tunnel che passava dalla Striscia di Gaza a Israele: Hamas è stata accusata di togliere i materiali da costruzione ai legittimi beneficiari prestabiliti. Intanto, anche il cemento già arrivato non può essere utilizzato perché mancano le autorizzazioni a spostarlo.
Dopo tutta la fatica che è servita per raccogliere i fondi necessari, lo stop forzato dei lavori suona come una beffa. Ma le fondamenta dell’asilo, almeno quelle, sono state gettate e nessuno ha intenzione di rinunciare a completare quel progetto su cui verrà impresso il nome di Simone. Perché la rinascita dell’asilo è un modo per tenere viva la sua memoria e perché lui, per la gente di Gaza, era uno di loro.
A distanza di mesi, quell’asilo sta rinascendo pezzo dopo pezzo grazie all’iniziativa di quanti l’avevano voluto in origine e anche grazie al contributo della famiglia del giovane giornalista. E proprio a lui verrà dedicata quella struttura che, nonostante gli ostacoli posti dalle autorità israeliane, cerca ancora di accogliere decine di bambini palestinesi.
Era il marzo del 2012 quando a Um al Nasser, villaggio beduino della Striscia di Gaza, si faceva festa per l’inaugurazione di un nuovo asilo. Aule per attività educative e ricreative, una mensa, un ambulatorio pediatrico e uno sportello di assistenza per le famiglie, c’era tutto quello che poteva servire all’interno della “Terra dei bambini”. Questo il nome della struttura realizzata con il contributo, tra gli altri, del nostro ministero degli Affari esteri, della Cooperazione italiana, della Conferenza episcopale e dell’organizzazione non governativa “Vento di Terra”, e progettata dallo studio di architettura Arcò insieme a quello di Mario Cucinella. Quel centro era diventato un laboratorio di buone prassi, un simbolo di speranza e un punto di riferimento per la popolazione di Um al Nasser.
Situato vicino al valico di Eretz, sul confine della cosiddetta “No go zone”, e circondato dai bacini di raccolta delle acque nere provenienti da tutto il nord della Striscia, il villaggio ha il 95 per cento di abitanti registrati come rifugiati, di cui il 60 per cento bambini, e un tasso di disoccupazione all’80 per cento, quasi il doppio della media regionale della Striscia. Um al Nasser, in piena area di conflitto tra Palestina e Israele, deve fare i conti con gli attacchi da parte dell’esercito israeliano. E la guerra lascia dietro di sé macerie e una serie di problematiche sanitarie e sociali. Per questo, alla “Terra dei bambini” erano previste pure attività di assistenza medica e psicologica per le sindromi da stress post-traumatico, oltre a servizi di sostegno per le mamme in difficoltà.
Un polo d’eccellenza, insomma: costruito in base a un progetto di architettura bioclimatica, dotato di pannelli fotovoltaici e di un impianto di fitodepurazione, l’asilo era stato realizzato con materiali poco costosi, facilmente reperibili sul territorio e particolarmente adatti a garantire l’isolamento e la funzionalità energetica della struttura.
Anche dal punto di vista dell’offerta formativa, la “Terra dei bambini” era un centro innovativo: gli insegnanti seguivano metodi pedagogici basati sul coinvolgimento diretto e sulla cosiddetta “educazione alla pace”. Un percorso per recuperare generazioni traumatizzate dalle violenze, per allontanarle dal rischio della radicalizzazione, per impedire che rabbia e dolore sfociassero nel desiderio di vendetta e nell’adesione al fondamentalismo.
Un percorso che è stato interrotto nella notte del 17 luglio 2014, quando la fanteria e i blindati israeliani impegnati nell’operazione “Protective Edge” hanno occupato il villaggio, obbligando l’intera comunità ad abbandonare le proprie case. I civili si sono diretti a piedi, sotto un intenso bombardamento, verso il campo profughi di Jabalia, dove sono stati costretti a vivere nella scarsità di medicinali, cibo e acqua potabile.
Al villaggio, intanto, le ruspe abbattevano un centinaio di abitazioni e la “Terra dei bambini”. Secondo le autorità israeliane, infatti, l’asilo serviva da copertura alle attività militari delle truppe islamiste e nascondeva l’accesso a tunnel che consentivano di uscire clandestinamente da Gaza. Accuse respinte dai gestori dell’asilo e mai verificate in concreto.
In quello stesso periodo Simone Camilli era rientrato a Gaza per documentare, per conto dell’agenzia “Associated Press”, la ripresa del conflitto e, in particolare, il problema delle bombe israeliane rimaste inesplose sul terreno. Il 13 agosto, insieme al cronista Ali Shehda Abu Afash che gli faceva da interprete e al fotografo Hatem Moussa, accompagnò una squadra di artificieri della polizia di Gaza per riprenderli con la sua telecamera.
Nel corso delle operazioni di disinnesco di un missile vicino a un campo di calcio a Beit Lahiya, la deflagrazione improvvisa dell’ordigno ha ucciso lui, l’interprete e tre poliziotti, mentre il fotografo è rimasto ferito.
Simone aveva già lavorato in aree di conflitto e, in particolare, nella Striscia: era stato lì nel 2012 per seguire l’operazione israeliana “Pilastro di Difesa”, nel 2011 per il rilascio di alcuni prigionieri palestinesi in cambio della liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit, tra il 2008 e il 2009 per l’operazione “Piombo Fuso” ed era stato lì anche negli anni precedenti per seguire altri eventi cruciali. Perché era così che intendeva la sua professione: voleva stare dove le cose succedono per vederle e raccontarle, voleva stare in prima linea, consapevole dei rischi e, insieme, della responsabilità che un giornalista ha nel descrivere la realtà. E anche in quell’estate di due anni fa, tra altri eventi che avrebbe potuto seguire per conto dell’agenzia, aveva scelto di tornare proprio a Gaza, nella terra che conosceva meglio e a cui aveva dedicato il documentario “About Gaza”, per continuare a testimoniare i risvolti umani e quelli meno noti della guerra. Per questo, grazie alla sensibilità e alla discrezione con cui raccontava la vita, le storie e le persone, era diventato un amico e un fratello per tutti coloro che aveva conosciuto sul posto.
Così, per rendere giustizia al coraggio e alla passione di Simone, ma anche per proseguirne l’impegno in quei territori a cui era profondamente legato, la sua famiglia ha deciso di sostenere progetti a favore della popolazione di Gaza. E l’idea di raccogliere fondi per ricostruire l’asilo di Um al Nasser è nata con la collaborazione di un amico di Simone, responsabile dei progetti a Gaza per conto di “Vento di Terra”.
Così, l’anno scorso i lavori sono partiti. È stato ricostruito e inaugurato il centro dedicato alle attività per le donne, dotato di un laboratorio di falegnameria e uno di sartoria, mentre la “Terra dei bambini” è stata temporaneamente riaperta in un edificio messo a disposizione dal Comune. Circa 130 bambini sono tornati a respirare un po’ di serenità tra le mura del loro asilo. Anche l’ambulatorio ha riaperto e sono ricominciate le attività di assistenza familiare e professionale.
Ma le difficoltà non mancano. I locali che ospitano il centro non sono abbastanza grandi e non sono sempre adeguati per il tipo di attività che vi si svolge. E il problema vero è che il progetto originario di ricostruzione è bloccato a causa del divieto d’importazione del cemento, imposto lo scorso aprile dal governo israeliano a tempo indeterminato. Il blocco è stato applicato in seguito alla scoperta di un tunnel che passava dalla Striscia di Gaza a Israele: Hamas è stata accusata di togliere i materiali da costruzione ai legittimi beneficiari prestabiliti. Intanto, anche il cemento già arrivato non può essere utilizzato perché mancano le autorizzazioni a spostarlo.
Dopo tutta la fatica che è servita per raccogliere i fondi necessari, lo stop forzato dei lavori suona come una beffa. Ma le fondamenta dell’asilo, almeno quelle, sono state gettate e nessuno ha intenzione di rinunciare a completare quel progetto su cui verrà impresso il nome di Simone. Perché la rinascita dell’asilo è un modo per tenere viva la sua memoria e perché lui, per la gente di Gaza, era uno di loro.